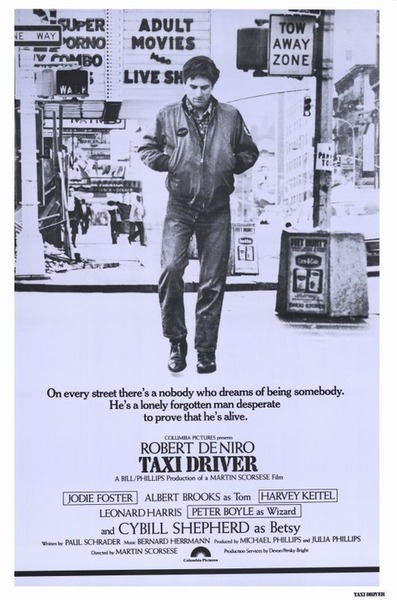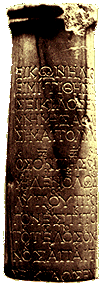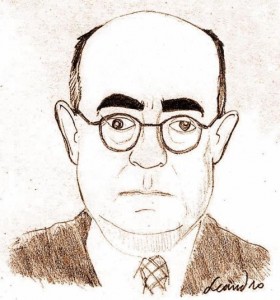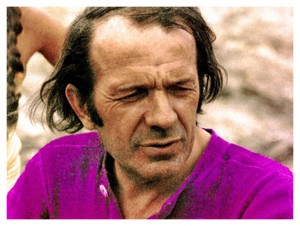Se ordini il libro tramite il nostro link hai diritto ad uno sconto significativo (Amazon): Storia della bruttezza (Tascabili. Saggi)
— — —

Romanzo di Esopo I (I-II secolo d.C). "Esopo, il grande benefattore dell’umanità (...) repellente, schifoso, pancione, con la testa sporgente, camuso, gibboso, storto, labbrone..."
Che cosa è il brutto? Che cosa è brutto? Solitamente si definisce il brutto in opposizione al bello; ma essendo il bello piuttosto soggettivo, anche la nozione di brutto non può essere univoca. Il bello e il brutto sono relativi a tempi diversi, a culture diverse, anche se nei secoli si è cercato più volte di definire dei modelli per definire cosa fosse bello e cosa non lo fosse (ne è uno dei massimi esempi il Canone di Policleto, una statua nella quale aveva racchiuso tutte le regole per le proporzioni ideali).Nella Storia della bruttezza a cura di Umberto Eco, viene presentata, partendo dal mondo classico sino ad arrivare al giorno d’oggi, la nozione di bruttezza, accompagnata da una lunga serie di opere d’arte che possono far comprendere tali concetti. Il testo comincia cercando di sfatare uno dei miti più diffusi legato al mondo classico: non era sicuramente un mondo dominato dal bello come molti credono. “L’ideale greco della perfezione era rappresentato dalla kalokagathia, termine che nasce dall’unione di kalos (genericamente tradotto come “bello”) e agathos (tradotto come “buono”).” Potremmo tradurre il concetto con il termine anglosassone gentlemen, persona di aspetto dignitoso, composta, ma che nello stesso tempo presenta un temperamento, un carattere fiero, coraggioso, dagli alti valori morali. Proprio alla luce di questo ideale, il mondo greco ha elaborato una vasta letteratura sul rapporto tra bruttezza fisica e bruttezza morale. La bruttezza e la malvagità erano aspetti molto indagati dai greci: osservate gli innumerevoli cortei di Bacco, con i sileni ebbri e ripugnanti, che a volte fanno sorridere tanto comicamente vengono rappresentati. La malvagità però non è sempre legata all’aspetto: l’orribile sileno per eccellenza è Socrate, maestro di saggezza. E non è sempre legata all’individuo maschile: ci sono figure come le sirene che la mitologia ha spesso rappresentato come uccellacci rapaci dalla coda di pesce. La loro malvagità sta nella voce, come ricorda l’Odissea: “Chiunque i lidi incautamente afferra- delle Sirene, e n’ode il canto, a lui- né la sposa fedel, né i cari figli- verranno incontro su le soglie in festa-“. Un fascino pericoloso e distruttivo.