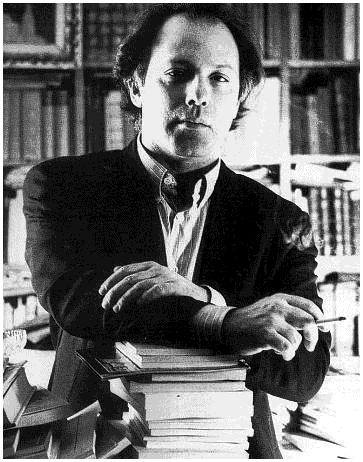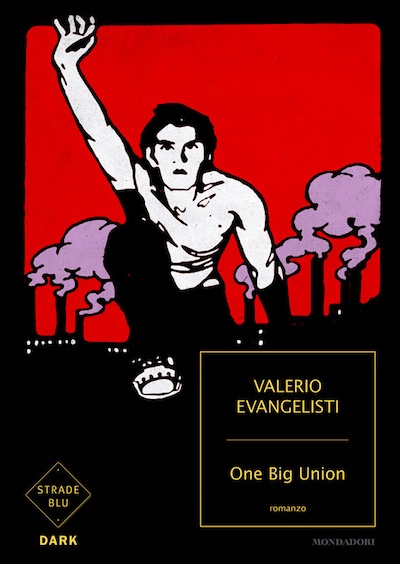“Più elevato il sogno, più fiera la sofferenza”
“Più elevato il sogno, più fiera la sofferenza”
E’ quanto afferma nel romanzo Il resto di Niente Cirillo, uno tra gli eroi della repubblica napoletana, instaurata nel gennaio 1799 sulla scia della campagna napoleonica in Italia, rivolgendosi ad Eleonora Pimentel Fonseca, tra le principali protagoniste di quella fase storica, la realizzazione di un sogno di libertà che ebbe vita breve e portò via la vita di molti patrioti.
Eleonora Pimentel Fonseca, intellettuale e scrittrice, fu una rivoluzionaria e fu impiccata nell’agosto del 1799, quando a Napoli si instaurarono nuovamente i Borboni e i repubblicani furono condannati a morte. Tra gli ultimi pensieri, prima di essere impiccata: “Servirà un giorno ricordare tutto questo?”.
Eleonora, però, non era nata a Napoli ma era portoghese. Arrivata a Napoli bambina con la sua famiglia, decise di appartenere a quella città, a Castel Sant’Elmo, a Toledo e ai vicoli straripanti di gente, al mare scintillante e al Vesuvio tanto bello quanto indifferente. Alla grandezza e alla povertà di quella capitale del Regno dei Borboni, già alla fine del Settecento centro di una struggente bellezza.
Lo scrittore Enzo Striano (1927-1987) tratteggia Eleonora Pimentel Fonseca in modo delicato e mai retorico, tra storia e letteratura. Enzo Striano accompagna la piccola Lènor nel suo arrivo a Napoli durante la feste della Piedigrotta: «Fu terrorizzata. Non aveva mai visto tanto e così vario clamore, né visto simile folle. La carrozza faticava a muoversi […] Un urlìo continuo, ritmato incessantemente dallo scuotere secco di mille tamburelli a sonaglia, dal soffiare di mille fischietti, dal frenetico strofinio di mille pentole […] Vide un uomo con sudicio berretto bianco e grembiule di cuoio che bolliva maccheroni su un fornello quasi in mezzo alla via. Rimase incantata per la velocità con la quale colui toglieva dal fuoco uno dei pentoloni che vi fumavano, ne rovesciava l’acqua, appiccicosa, biancastra, senza far cadere neppure un filo della pasta, che poi serviva, con rapidità impressionante, nei piatti di stagno degli avventori che allungavano il braccio nella ressa».
Fin da bambina Lènor mostra una propensione e un interesse per gli studi umanistici e scientifici; arrivata all’adolescenza inizia a comporre poesie che legge nei salotti dell’aristocrazia di Napoli e a Corte, al cospetto dei sovrani Ferdinando IV e Maria Carolina.
Enzo Striano, attraverso la descrizione della vita di Lènor negli ambienti vicini alla Corte, elabora un affresco della Napoli di fine Settecento dove avevano iniziato a diffondersi largamente idee e principi di matrice illuminista.
Eleonora Pimentel Fonseca studia Genovesi, Filangeri e segue le notizie che provengono dal resto del mondo: la rivoluzione americana e la pubblicazione della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, gli avvenimenti in Francia dove il nuovo re Luigi XVI stava per essere travolto (e ghigliottinato) dalla Rivoluzione del 1789.
Lènor si allontana sempre più dalla Corte: fiorisce in lei una visione del mondo che si oppone ad un potere che sfrutta l’ignoranza e la debolezza della maggioranza del popolo e abbraccia un progetto che avrebbe dovuto coinvolgere gli intellettuali illuminati nella missione di liberare il popolo. Ma Eleonora si accorge che non è così semplice e che spesso è proprio quel popolo da liberare che si trasforma nel nemico più violento.
Nelle pagine del romanzo, la Grande Storia si intreccia alla vicenda privata di Lènor che, rimasta senza la mamma e in condizioni economiche precarie, decide di sposarsi con un esponente della piccola nobiltà napoletana. Fu un’esperienza agghiacciante per la sensibile e colta protagonista, segnata dalla violenza domestica e drammaticamente dalla perdita del piccolo figlioletto. Lènor, con il sostegno del padre, divorzia e si dedica a quello che viene descritto nel libro “fare come gli uomini: partorire con il cervello”.
Enzo Striano tratteggia mirabilmente il personaggio di questa giovane donna: attraverso i suoi flussi di coscienza possiamo affacciarci nella sua anima per leggerne i turbamenti, i dubbi, le riflessioni.
I lazzari, il popolo basso, sono il personaggio corale al centro del romanzo: «Anche quelli sono popolo, Lènor. Non ci capiscono perché vivono nell’arretratezza, nella sporcizia. Ci odiano. Hanno paura anche di noi. Ma noi dobbiamo lavorare anche per loro: noi abbiamo avuto tutto, loro niente».
Proclamata la Repubblica, Eleonora Fonseca dirige il giornale “Il Monitore Napoletano”, organo di stampa ufficiale del nuovo Governo. Scrive articoli educativi con la missione di formare il popolo: per lei la cultura è missione civile perché solo l’istruzione può liberare ed elevare i lazzari.
Il suo entusiasmo però si contrappone ad un senso del Fato inevitabile che viene espresso dal personaggio di Pulcinella: «Pulcinella non è un tipo allegro. Sa le cose nascoste. Ca la Repubblica adda fernì, come finisce tutto, ca ll’uommene se credono de fa chesto, de fa’ chello, de cagnà lo munno, ma non è vero niente. Le cose cambiano faccia, non sostanza: vanno sempre come hanno da ì. Comme vò lo Padrone. Lo munno non po’ girà a la mano smerza. Lo sole spunta tutte li mmattine e poì scenne la notte, la vita è ‘na jurnata che passa: viene la morte e nisciuno la po’ ferma’. Perché è de mano de lo Padrone: di Dio. Pulcinella queste cose le ha sapute sempre, come volete che si metta a fare il giacobino? Lo po’ pure fa’, ma solo per far ridere, per soldi. Isso non ce crede».
I lazzari vogliono essere lasciati in pace: «Sempre il vecchio problema: s’ha diritto di far felici gli altri imponendogli quella che riteniamo sia felicità? Felicità comporta sacrifici, s’ha diritto ad imporli a chi pensa non valga la pena di farli? Mettetevi le scarpe, imparate il gergo repubblicano, fatevi ammazzare per cacciare i Borboni, i Ruffo, i preti, l’ignoranza (e così regalate alla Gran Repubblica Madre i palazzi del re, Capodimonte, Ercolano), studiate, diventate colti. Leggete Genovesi, Filngieri, distruggete Pulcinella, san Gennaro, vicoli, bassi, la vostra vita randagia».
Sullo sfondo la Gran Repubblica Madre, la Francia, che dopo aver rapinato risorse dalla Repubblica Napoletana, abbandona i patrioti al loro tragico destino.
Eleonora Fonseca nel suo ultimo giorno di vita chiese in prigione una tazza di caffè. Probabilmente il suo ultimo pensiero davanti al boia è stata la soddisfazione di aver compiuto il suo dovere.
Il nostro dovere, oggi, è ricordarla e farla vivere nella nostra storia.
E ricordare il romanzo di Enzo Striano, Il resto di niente.
Come si dice a Napoli, o resto è niente.
— — —
(articolo di Eleonora Corgiolu)