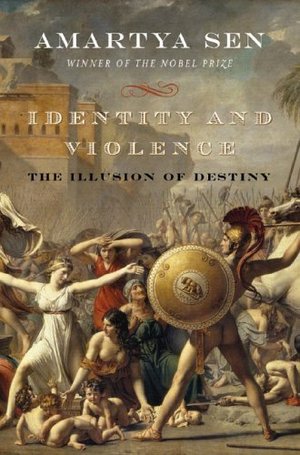Si è già detto molto sul prossimo voto. Troppo. Forse troppo poco. Quello che rimarrà, comunque vada, sarà una barchetta “tecnica” di salvataggio su cui saliranno solo poche persone mentre tutte le altre saranno condannate a colare a picco, nel sonno, su una nave colabrodo. In un mare neanche in tempesta. Senza bande ad annunciare la tragedia. Silenziosamente. Senza clamore.
Berlusconi, Monti, Bersani e Grillo. Quattro macchine da guerra. Più o meno gioiose. Quattro generali al comando di quattro eserciti in continuo contatto. Impeto e tempesta sui palchi, negli spettacoli televisivi, dentro la “rete”. Confondere e comprare. Confondere e comprare. Confondere e comprare. Perchè i confini della politica sono così sconfinati che anche le verità si dimezzano in un brodo primordiale di vanità, ilarità statisticamente programmata, apparenze di serietà e rigore. Cosa rimarrà di questa lunga marcia? Il Parlamento. Solo il Parlamento. Il Parlamento del 26 febbraio sarà il vero centro di una grande ricomposizione istituzionale che sembrerà cambiare tutto per non cambiare nulla. Saranno pezzi in movimento a seconda degli interessi della “governabilità”. Sarà un Governo dei sopravvissuti. Niente di più e niente di meno. Berlusconi, Monti, Bersani e Grillo. Quattro generali in attesa del risultato. Quattro pattuglie parlamentari. Quattro quantità sulla bilancia del Parlamento. La nuova Costituzione sarà un libro di algebra. Quattro flussi che si incroceranno per dare vita al nuovo Governo. Non sarà il Governo degli uomini e delle donne. Non sarà il Governo degli Esseri viventi che ogni giorno devono fare i conti con la propria quotidianità. Sarà il Governo dell’equilibrio. Sarà il Governo della Tecnica. Sarà il Governo del Comando. Il Governo della paura di non riuscire a governare. Le nostre Vite continueranno ad essere le nostre Vite. Niente di più. Niente di meglio. Sempre peggio.
L’unica novità sarà la quantità parlamentare che Grillo porterà in dote alla governabilità. Sarà la dote di un movimento che è cresciuto costantemente. Allontanandosi e riavvicinando. Tessendo le contraddizioni di un popolo in libera uscita. Grillo ha generato appartenenza. Ha creato una forma di liberazione. Un metodo. Il VaffaPensiero. Ha strutturato questo VaffaPensiero in qualche regola precisa. Un po’ come si fa con i segnali stradali. E’ stato studiato, analizzato, paragonato. Ha fatto spendere fiumi di parole a giornalisti ed opinionisti di vario genere, razza ed età. Tutto inutile. La dote di Grillo sarà una pattuglia costantemente corteggiata da destra e da sinistra. Sarà il trasformismo fatto a sistema. Perchè non c’è destra e sinistra, ci sono solo loro. L’oro. Eppure, per quanto si possa pensare come “nuovo”, Grillo è un’anomalia sistemica che storicamente il nostro ventre ripropone. E’ la prova che abbiamo un rimosso con cui fare i conti. Un rimosso che si presenta puntualmente in forma diversa. E’ una necessità di odiare. Di creare un nemico su cui riversare la propria disperazione. Un capro.
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma. Le istituzioni andrebbero attraversate per trasformarle. Come il fattore che attraversa la terra per prepararla ad accogliere i germogli del futuro da cui prendere i frutti sani dell’emancipazione. Ma il 26 febbraio non ci saranno frutti da cogliere. Solo loro. Solo l’oro.






 Scrivere solo oggi un commento a “Roma combattente” e “Bastardi senza Storia” di Valerio Gentili (edizioni Castelvecchi) potrebbe sembrare superfluo perchè, almeno il primo libro, è in commercio dal lontano aprile del 2010 ed a distanza di due anni e mezzo non è scontato che un testo continui a mantenere una certa potenza creativa conservando uguale capacità di analisi. Anche solo per il fatto che le situazioni possano cambiare enormemente. In realtà è proprio in questo momento che l’operazione storiografica promossa dall’autore ci sembra assumere maggiore evidenza. Il deflusso della stagione “no global” (o “new global”, “alter global” e via dicendo come dir si voglia) e la ripresa di un ciclo di conflittualità dalla fine del 2010 fino ad oggi racconta una storia dell’antagonismo estremamente frastagliata e composita. Non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo. Naturalmente tra ieri (il periodo preso in considerazione dal libro, dal
Scrivere solo oggi un commento a “Roma combattente” e “Bastardi senza Storia” di Valerio Gentili (edizioni Castelvecchi) potrebbe sembrare superfluo perchè, almeno il primo libro, è in commercio dal lontano aprile del 2010 ed a distanza di due anni e mezzo non è scontato che un testo continui a mantenere una certa potenza creativa conservando uguale capacità di analisi. Anche solo per il fatto che le situazioni possano cambiare enormemente. In realtà è proprio in questo momento che l’operazione storiografica promossa dall’autore ci sembra assumere maggiore evidenza. Il deflusso della stagione “no global” (o “new global”, “alter global” e via dicendo come dir si voglia) e la ripresa di un ciclo di conflittualità dalla fine del 2010 fino ad oggi racconta una storia dell’antagonismo estremamente frastagliata e composita. Non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo. Naturalmente tra ieri (il periodo preso in considerazione dal libro, dal  Dopo la trilogia è arrivato anche il (non) Manifesto e si presenta un po’ come i titoli di coda di un lavoro lungo circa un decennio. È questo il percorso del ticket Hardt & Negri, che ancora continua a snocciolare teoria per allietare le prospettive del movimento ed estenderne le capacità di conflitto e di organizzazione. Già in “
Dopo la trilogia è arrivato anche il (non) Manifesto e si presenta un po’ come i titoli di coda di un lavoro lungo circa un decennio. È questo il percorso del ticket Hardt & Negri, che ancora continua a snocciolare teoria per allietare le prospettive del movimento ed estenderne le capacità di conflitto e di organizzazione. Già in “