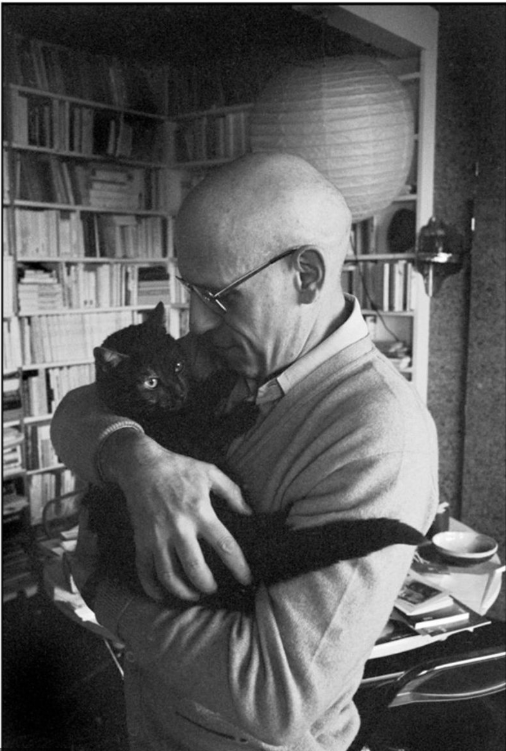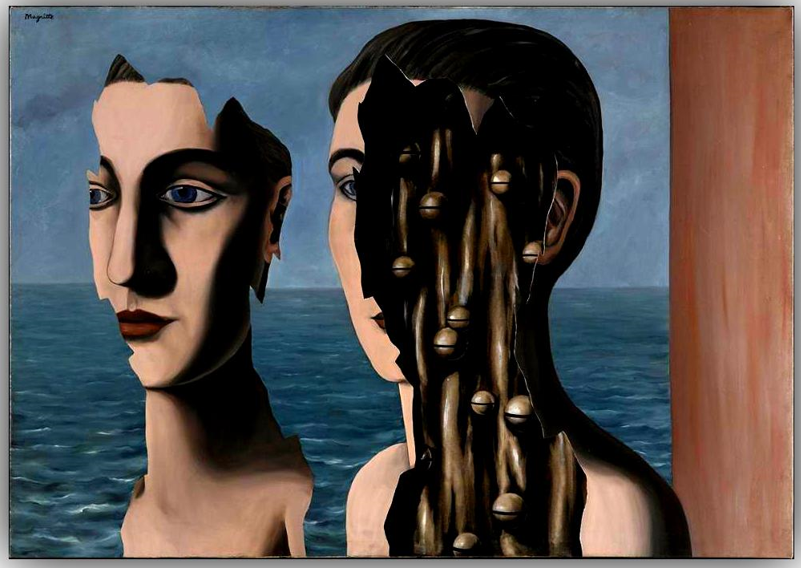Questo piccolo brano è l’ultima “Bustina di Minerva” raccolta nel libro “Come viaggiare con un salmone” (2016). Ci sembrava doveroso pubblicarla, proprio per coloro che vogliono avvicinarsi alla filosofia con qualche prezioso consiglio di Umberto Eco. Ad ogni fine segue sempre un inizio, o almeno, così dovrebbe essere.
Questo piccolo brano è l’ultima “Bustina di Minerva” raccolta nel libro “Come viaggiare con un salmone” (2016). Ci sembrava doveroso pubblicarla, proprio per coloro che vogliono avvicinarsi alla filosofia con qualche prezioso consiglio di Umberto Eco. Ad ogni fine segue sempre un inizio, o almeno, così dovrebbe essere.
— — —
Sarà perché la gente non sopporta più la televisione spazzatura, sarà perché nel mondo accadono tante cose brutte che si sente il bisogno di alcuni momenti di riflessione rasserenata, ma si stanno moltiplicando i luoghi e le occasioni in cui al grande pubblico si ripropone la filosofia. Proprio quella del liceo, magari in un caffè dove ci si riunisce la domenica, come a Parigi, o attraverso volgarizzazioni di facile lettura, talora facendo accorrere un pubblico incredibilmente vasto in sale dove discutono i filosofi professionisti.
In tutto questo c’è della moda e della semplificazione massmediatica, certo, ma il sintomo non è da sottovalutare. Pertanto mi viene in mente di fare alcune proposte per i non specialisti, anche per coloro che la filosofia non l’hanno studiata al liceo, o che sono andati ad ascoltare dei presunti filosofi che parlavano da qualche parte e non hanno capito nulla. A tutti costoro consiglio la via più semplice: leggere quanto hanno scritto i veri filosofi.
Non sempre la filosofia deve apparire facile, talora deve essere difficile, ma non sta scritto da nessuna parte che per filosofare occorra parlare difficile. La difficoltà del linguaggio – in filosofia – non è segno né di qualità né di perversità, spesso dipende dal problema che si affronta. Ci sono capolavori filosofici, che hanno cambiato il nostro modo di essere e di pensare, i quali sono fatalmente difficili, per cui non inviterò nessuno, che non sia specializzato, a leggere la ‘Metafisica’ o ‘L’Organon’ di Aristotele, la ‘Critica della ragion pura’ o quel libro sublime ma impervio che è l”Etica’ di Spinoza. Ma ci sono anche filosofi che hanno saputo parlare in modo accessibile e spesso sono gli stessi che in altre opere hanno parlato in modo inaccessibile. Pertanto consiglio solo alcuni libretti (ciascuno dei quali si aggira in media intorno al centinaio di pagine) in cui si vede come si possa filosofare senza usare troppi termini tecnici.
Cominciamo con Platone. Proporrei il ‘Critone’, dove si impara come e perché un cittadino non debba sfuggire all’osservanza delle leggi (che si chiami Socrate o Silvio) e, passando ad Aristotele, la ‘Poetica’. Dimenticate che parla della tragedia classica. Leggetelo come se ci descrivesse come si fa un romanzo giallo o un film western. Il nostro uomo aveva già capito tutto quello che più di duemila anni dopo avrebbero capito Hitchcock o John Ford. Quindi si legga il ‘De magistro’ di Sant’Agostino: parla di come si parla a un figlio su cose di tutti i giorni. Un libretto geniale per semplicità e acutezza.
Pur essendo cultore del Medioevo, trovo difficile consigliare un testo della grande epoca scolastica, perché poche pagine, lette fuori dal loro contesto sistematico, possono risultare fuorvianti. Saltiamo il fosso, quello strettamente filosofico, e orientiamo il nostro lettore sull’epistolario (eh sì, amoroso) di Abelardo ed Eloisa. Non aspettatevi troppo sesso, ma vale la pena.
Per il Rinascimento, proviamo con l’orazione sulla dignità dell’uomo di Pico della Mirandola. E poi (ma solo per antologia, e ce ne sono) qualche passaggio dai ‘Saggi’ di Montaigne. Vanno bene anche a dosi omeopatiche. Subito dopo, il ‘Discorso del metodo’ di Cartesio, esemplare per chiarezza, quindi una antologia dai pensieri di Pascal. E infine un filosofo che scriveva come se stesse parlando dopocena coi suoi amici, colto e assennato, il John Locke del ‘Saggio sull’intelletto umano’. L’opera intera è lunga, ma direi di limitarsi al terzo libro, quello dedicato all’uso che facciamo delle parole. Come per Aristotele, leggetelo come se Locke ci parlasse dei discorsi di oggi, confrontate le sue osservazioni con le prime pagine dei giornali e coi dibattiti televisivi dei giorni nostri.
Per l’illuminismo, mi limiterei per ora al ‘Candido’ di Voltaire; alla fin fine si tratta di un romanzetto, e gradevolissimo. L’Ottocento è una brutta bestia, sono libroni difficili, ma siamo solo noi italiani che non consideriamo lo ‘Zibaldone’ di Leopardi un’opera di alta filosofia. Recentemente in Francia lo hanno ricuperato con immenso rispetto. Anche lì, andiamo per salti antologici, una paginetta o due alla sera prima di addormentarsi. Oppure faccio una proposta provocatoria. Visto che Kant è per definizione troppo esigente, andiamo a incontrarlo là dove, per arrotondare lo stipendio, faceva lezioni agli studenti su argomenti su cui non era specializzato, e si dimostrava spiritoso, bizzarro, capace di raccontare aneddoti e di esprimere opinioni anche paradossali: leggiamoci cioè le sue lezioni di antropologia. Il titolo può fare paura ma il testo è da alto rotocalco.
E poi? E poi lo spazio per la Bustina è terminato e lascio perdere i contemporanei. A meno che non vogliate, saltellando qua e là, centellinare alcune delle osservazioni di Wittgenstein in (non fatevi spaventare dal titolo) ‘Ricerche filosofiche’. Ogni tanto direte che era matto. Sì, era matto. Ma che matto.