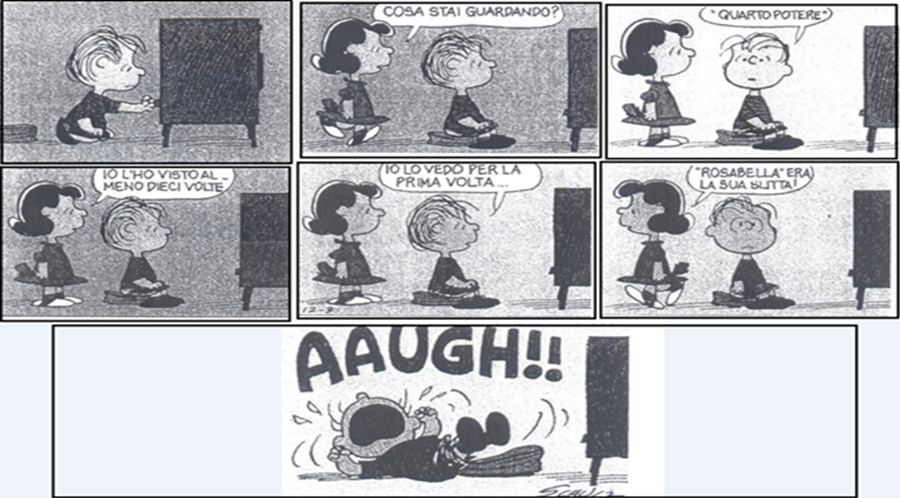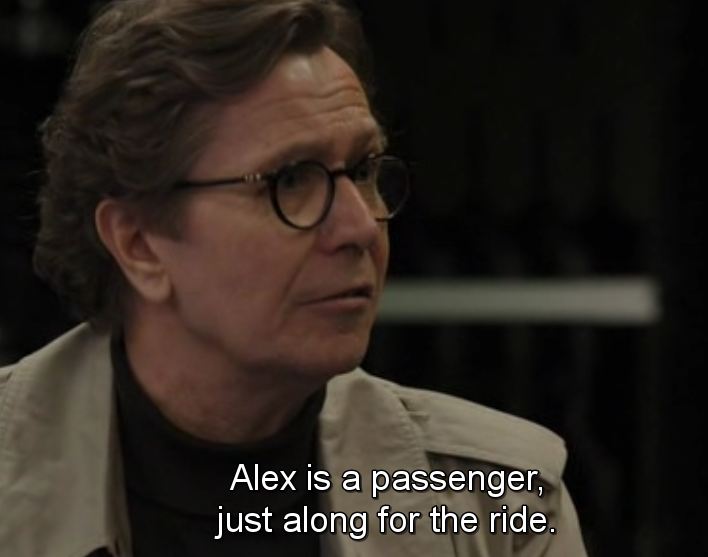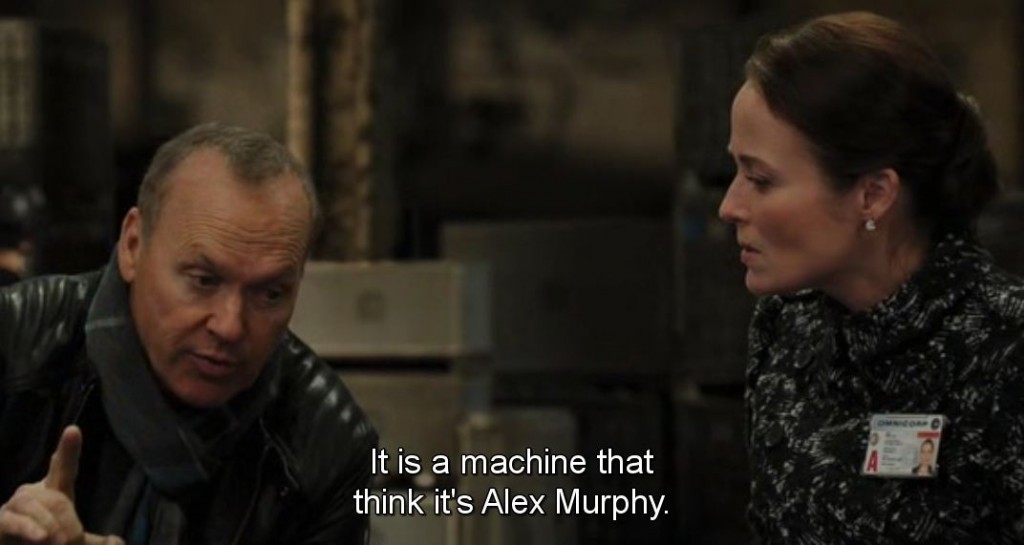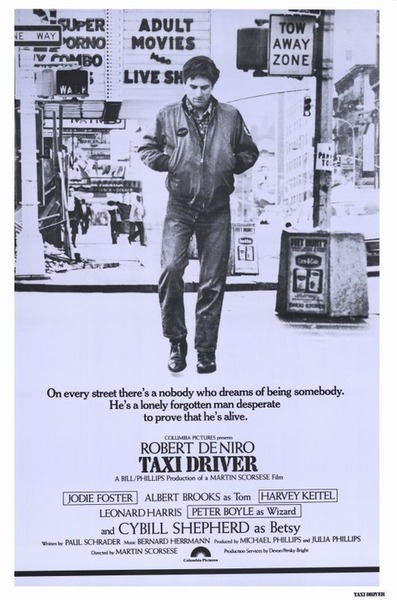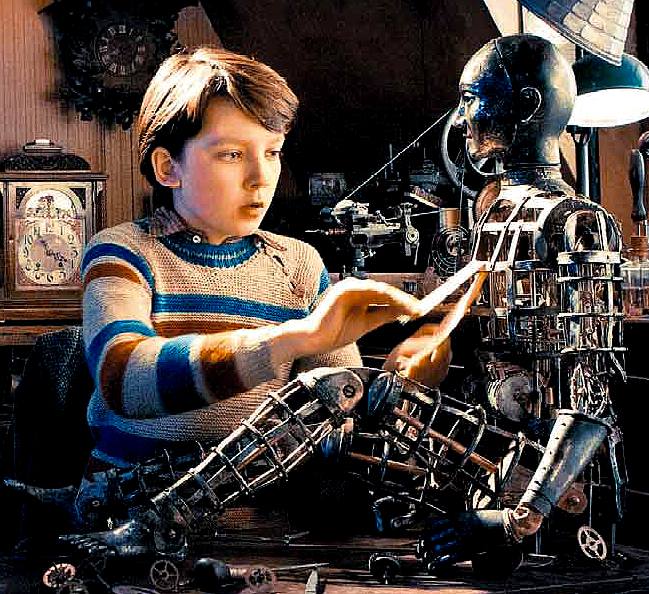“Non si può certo dire che l’immaginazione mitica sia scomparsa; è ancora con noi, avendo solo adattato il suo funzionamento al materiale ora a nostra disposizione” (Mircea Eliade)
“Il fanatismo è cioè l’unica «forza della volontà» che possono conquistare anche i deboli e gli incerti, quasi una specie d’ipnosi di tutto il sistema sensitivo intellettuale a beneficio del nutrimento eccessivo (d’un’ipertrofia) d’un punto unico di visione e di sentimento; il cristiano la chiama la sua fede” (Friedrich Nietzsche)
Il secondo capitolo cinematografico della saga di Dune diretto da Denis Villeneuve e tratto dal primo libro di Frank Herbert è un lungo e maestoso saggio visivo sul modernissimo problema teologico-politico dei rapporti tra sacro e potere. E di come il vero destino dell’umanità, nel male come nel bene, sia nella vittoria del Sacro, una forza che distruggerà qualsiasi resistenza, che si chiami Impero, Scienza o Capitale (il controllo della preziosissima Spezia). Lo spaventoso destino messianico del Sacro è creare un deserto, come il pianeta Arrakis, perché il sacro è una forza incredibilmente più pervasiva, coinvolgente e invasiva di tutte le altre che popolano il mondo umano. Ci si può alleare con esso? Lo si può controllare? (nello stile machiavellico dell’ordine religioso delle Bene Gesserit). Lo si può soggiogare ai propri fini? Ci si possono fare cauti passi di liberazione insieme? Oppure nella sua spaventosa forza, il Sacro (e le nuove sacralizzazioni) si dimostra alla fine della storia come il vero nemico? Sono tutti temi che emergono scenograficamente nel film-colossal di Villeneuve.
Il genere fantascientifico pullula di mondi dominati da un progresso tecnologico oltre i nostri sogni (e incubi) più sfrenati. In questi mondi, spesso, la componente religiosa viaggia in sordina rispetto a quella politica e scientifico-tecnologica. Il primissimo “Star Trek“, probabilmente la saga di fantascienza più popolare di tutti i tempi, aveva forti sfumature antireligiose che riflettevano le idee neoilluministe e laiche del creatore, Gene Rodemberry. Nei romanzi di uno dei creatori della fantascienza del Novecento, Isaac Asimov, l’elemento religioso è semmai uno stadio culturale provvisorio nell’attesa dell’evoluzione futura dell’umanità e del razionalismo. Tuttavia, parallelo a queste creazioni narrative neopositiviste, c’è un mondo di fantascienza utopico (o distopico?) che si immerge nella spiritualità e nella religiosità e afferma il potere che queste forze hanno sulla società anche di fronte a un così vasto sviluppo scientifico: è il caso del ciclo di “Dune” di Frank Herbert.
I Fremen, gli abitanti del pianeta desertico Arrakis, seguono una religione messianica che ruota attorno a dei misteriosi grandi vermi del deserto e alla promessa di una figura che trasformerà il deserto in acqua e libererà i Fremen dagli oppressori. Uno dei temi principali del libro è la lotta dei personaggi principali per il dominio delle spezie di Arrakis, i quali spesso si confrontano con le credenze religiose dei Fremen, viste spesso come primitive, insulse, o diffuse ad arte dal gruppo femminile sacerdotale Bene Gesserit per poter controllare meglio questa strana e rude popolazione; alla fine, sono proprio le credenze dei Fremen che permettono al personaggio principale, Paul Atredies, di trionfare e compiere il suo destino. Non ci sono in Dune tecnologie troppo distanti dal nostro mondo (come arma definitiva ci sono ancora le nostre care testate atomiche). E non esistono più robot intelligenti e IA, poiché centinaia di anni prima dell’inizio delle vicende del libro una guerra contro di loro le ha sterminate tutte. Una vera e propria rivolta futura contro la tecnologia.
Frank Herbert, e di qui la (abbastanza) fedele trasposizione scenografica del regista Villeneuve, non sta sottolineando il trionfo della religione sulla scienza, né sta condannando esplicitamente la religione. Herbert rimane splendidamente ambiguo riguardo al prendere una decisione su questa annosa e un po’ striminzita dicotomia, come rimane grigio e nebuloso, a ben guardare, lo stesso Paul Atriedes. Eroe incerto per buona parte del film, Paul non crede a nessuna delle profezie che possono riguardarlo, esattamente come la sua compagna Fremen, Chani, quasi una cooprotagonista, che non cambierà mai idea sulla sua avversione al fanatismo religioso. E lo stesso Herbert non ci viene mai in soccorso: non abbiamo indizi per capire se questo universo religioso in cui tutti sono immersi sia misticamente vero o falso, o se solo qualcuna di queste profezie sia vera; Herbert si assicura di farci sapere che diversi personaggi sono scettici, ma nonostante ciò, gli stessi personaggi che fanno parte di questa storia si sforzano di realizzare queste profezie. Lo stesso Paul e sua madre, l’inquietante sacerdotessa Jessica, sono ambigui fino alle ultime scene del film. La tensione tra la verità della profezia, il suo uso come instrumentum regni e il desiderio di realizzarla è molto potente nell’opera di Frank Herbert come nel film, e spiega qualcosa di profondamente vero sul potere della religione come forza che influenza il comportamento degli esseri umani. Il potere della religione, nel mondo di Herbert, non corre perciò il pericolo di essere sostituito da quello razionale-scientifico; i due poteri non si trovano mai davvero in campi dicotomici in lotta fra di loro. Sono più che altro strumenti, che si ibridano, trasformano e che rimangono in agguato, oggi, come ieri, come fra ventimila anni.
Dunque, il futuro di Herbert ha una profonda continuità col presente: non solo i termini religiosi e antropologici dell’universo di Herbert sono presi dall’arabo, dal persiano e dal turco dei nostri giorni (a titolo d’esempio, basti pensare solo ai termini “jihad”, molto presente nel film, “mahdi”, “Shai Hulud”). Di più, Herbert studia la recente ri-sacralizzazione del mondo e la applica al futuro. Rifiuta perciò la contemporanea e nicciana “morte di Dio”, sostenendo che anche nel futuro più lontano, gli esseri umani saranno non solo religiosi, ma strapieni di Verità e narrazioni forti, di trasformazioni del Sacro. Dove poteva (e doveva) esserci il trionfo della ragione, oppure, in maniera più postmoderna, del liquido “non-senso”, assistiamo al trionfo di tribalismo, verità forti inconciliabili, universi veritativi incomunicabili. Quasi citando Nietzsche, che scriveva ne La gaia scienza: “dopo che Buddha fu morto, si continuò per secoli ad additare la sua ombra in una caverna – un’immensa orribile ombra. Dio è morto: ma stando alla natura degli uomini, ci saranno ancora forse per millenni caverne nelle quali si additerà la sua ombra. E noi – noi dobbiamo anche vincere la sua ombra!”
Tutta la modernità aveva dato per morta le Religione ed il Sacro. La fine della storia era vista come una potente ed inesauribile onda di globalizzazione, che avrebbe portato l’uniformità di idee (si presupponevano laiche, democratico-repubblicane) assieme a quella dello stile di vita e dei consumi. Non è andata così. Le magnifiche sorti progressive occidentali sono state in buona parte sconfitte. Le religioni ed il sacro hanno rappresentato negli ultimi anni come nello scorso secolo, con i loro infiniti camuffamenti e trasformazioni, un calderone di identità emergenti, tribalismi, organizzazioni statuali e parastatali, formali e informali, armate e non, esplosive e invasive, pronte a rovesciare ogni piano neoilluminista o neoimperialista. Il dibattito sulla modernità e sui suoi rapporti con la sfera del mito e del religioso è estremamente fecondo. È importante infatti mettere in luce le maniere con le quali la modernità abbia potuto (secondo alcuni aspetti) sacralizzare quasi tutte le sfere dell’umano, dalla politica, alla scienza, alla identità. Mentre decostruiva tutta una serie di fenomeni religiosi tradizionali, ha nel contempo destoricizzato quello che era il mondo “profano”, laico, proprio quel mondo cha andava purificando dal mito e dalle religioni tradizionali, spesso edificando altre strutture metastoriche e fissiste (surrogato di quelle tradizionali), strutture come la Storia, la Natura, lo Stato, la Nazione e la Scienza. La modernità, esattamente come la religione ed il mito, si è in effetti caratterizzata come una via maestra per dare “legittimità, ordine, coerenza ai significati socialmente condivisi” (la definizione è di Giovanni Filoramo per il termine “religione”). Tutta la modernità e la post-modernità può essere inquadrata (compreso il problema attualissimo tra Islam e Occidente; ma come non pensare anche alla promessa messianica della terra per gli Ebrei? O alla radicalizzazione e comparsa di Hamas? ) anche in questa sacralizzazione dell’ethos, dell’identità etnica e nazionale, conservando idealismi metastorici anche sotto forma di politica e scienza. Per gli storici delle religioni la nuova tappa più significativa di tale processo moderno e post-moderno si è ripresentata con tutta la sua carica significativa durante la decolonizzazione, ma anche dopo il crollo del Muro e l’11 settembre. Nell’età contemporanea, come durante la modernità, i nuovi scenari ideologici, anche i più insospettabili, sono l’esito di quel tipico lavorio destrutturante, che, mentre secolarizzava le varie sfere dell’esistenza umana, creava nel contempo al loro stesso interno l’esigenza di nuovi processi di senso e di sacralizzazione.
Ma il film di Villeneuve, pure con qualche inquietante accenno ad altre sacralizzazioni (la casata Harkonnen sembra aver costituito una spietata dittatura militare con annesso culto della personalità) presenta su Arrakis il Sacro nella sua spregiudicata e ambigua ascesa in funzione anticoloniale e antimperialista, fenomeno molto studiato negli studi post-coloniali. L’etnologo e storico delle religioni Vittorio Lanternari (nel campo di studi, omologo italiano dell’antropologo francese Georges Balandier), scuola sull’asse fecondissimo inaugurato in Italia da Ernesto de Martino, accantonando per un attimo l’idea marxiana un po’ sempliciotta di intendere la religione solamente come un “oppio dei popoli“, ha potuto studiare i legami inscindibili fra decolonizzazioni, incontro-scontro dei popoli e creazioni religiose, fra dominio coloniale e bisogno di libertà dei popoli oppressi. Il riferimento all’Islam nella space opera di Herbert è chiarissimo. L’Islam di Herbert, in parte, è legato al ruolo del sacro come ambigua fonte messianica e liberatrice (in una scena Villeneuve gioca pure col Cristianesimo, inscenando la resurrezione del messia-Atreides come inizio del nuovo culto). Da scrittore di fantascienza Herbert capì quello che il nostro etnologo Lanternari studiò sul campo: e cioè che le religioni cambiano, ora lentamente ora rapidamente, o nascono ex novo, in risposta alle nuove sfide sociopolitiche del tempo e del luogo. E non importa che le religioni possano essere uno stadio pre-politico di lotta, resistenza, riscatto o dominio. Sono infinitamente più efficaci del politico. Fra migliaia di anni, se sopravviveremo a noi stessi, l’intero universo sarà pieno di Islam e Cristianesimi, religioni messianiche, culti, chiese e sette simili ma anche diverse da quelle del presente e del passato.
Alessandro Stella