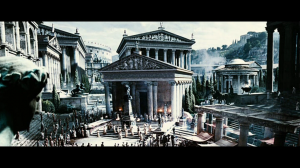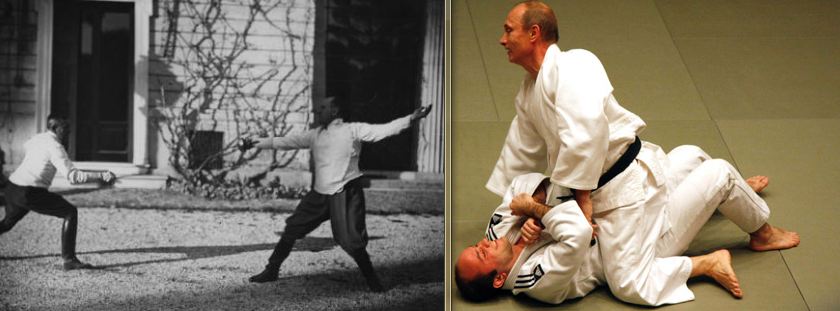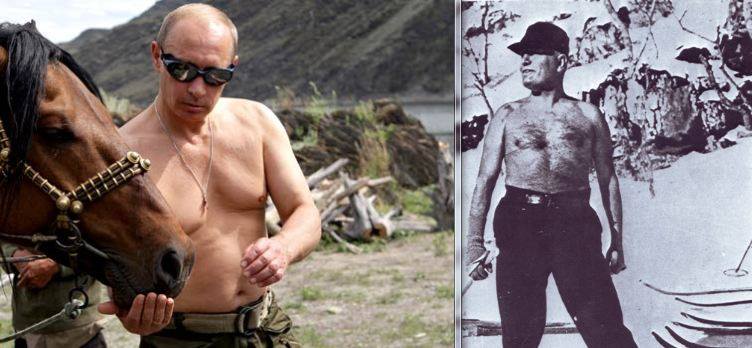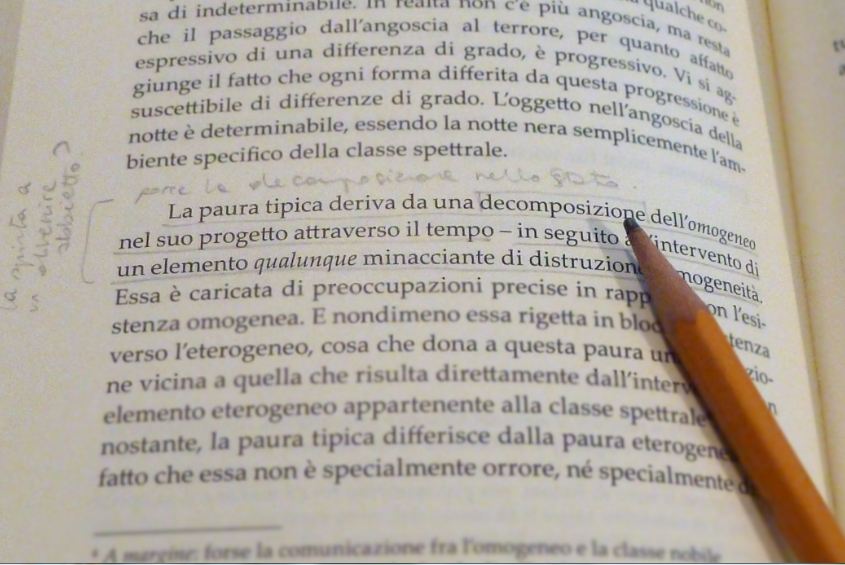Recensione a cura di Stefano Comito
 Sweet dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza è un saggio di Daniel Dennett, più precisamente è una collezione di articoli pubblicati dal filosofo americano, in cui espone le sue convinzioni su uno dei problemi più attuali all’interno della filosofia e della neuroscienza, ossia lo studio della coscienza. Con questo saggio Dennett ha vinto nel 2005 il premio per le pubblicazioni nell’ambito delle scienze cognitive.
Sweet dreams. Illusioni filosofiche sulla coscienza è un saggio di Daniel Dennett, più precisamente è una collezione di articoli pubblicati dal filosofo americano, in cui espone le sue convinzioni su uno dei problemi più attuali all’interno della filosofia e della neuroscienza, ossia lo studio della coscienza. Con questo saggio Dennett ha vinto nel 2005 il premio per le pubblicazioni nell’ambito delle scienze cognitive.
Nella prima parte del libro (cap1-4), Dennett disegna la svolta naturalistica nell’indagine sullo studio della coscienza; soprattutto nel primo capitolo, denuncia come buona parte della tradizione filosofica si comprometta aderendo a una metafisica vecchia di duecentocinquant’anni.
In seguito traccia il compito della scienza, ossia quello di indagare la coscienza tramite il metodo dell’eterofenomenologia, che consente di esaminare la coscienza da dati oggettivi. Di conseguenza, è negata la priorità di qualsiasi approccio in prima persona allo studio della mente umana; non c’è nulla che il metodo in prima persona possa dirci sulla coscienza e sugli altri fenomeni mentali che la scienza non possa scoprire. Dopo nega che esista uno spettacolo della coscienza che non possa essere spiegato da meccanismi cerebrali come fatto, all’inizio del secolo scorso, con il fenomeno del déjà-vu. Per ultimo, confuta la tesi dell’esistenza dei qualia, affrontando l’esperimento del change blindness: “i qualia sono la conseguenza di una teoria obsoleta, qualcosa che dovremmo tenere lontano dalla nostra esplorazione della coscienza”.
Nella parte centrale del libro (cap. 5), Dennett gira le manopole di quella pompa d’intuizione che è l’esperimento mentale di Mary, tanto caro ai dualisti. Per il filosofo americano non c’è niente che si possa sapere oltre alla descrizione di una teoria naturalista. Al termine, il filosofo americano (cap. 6-7) svela la sua teoria della coscienza riconducendola al modello della “fama” o “celebrità celebrale”, evoluzione della teoria delle Molteplici Versioni, cioè un’alternativa alla teoria tradizionale del Teatro Cartesiano secondo cui tutte le nostre esperienze coscienti si riuniscono in un luogo del cervello per essere esaminate dal soggetto. Dennett si contrappone a chi sostiene che la coscienza sia qualcosa di mistico, come predicano i teologi o un’entità misteriosa come asseriscono i filosofi dualisti, da Nagel a McGinn. Questi ultimi pensano che la coscienza sfugga alle concezioni della scienza, la quale studia la realtà in maniera oggettiva e impersonale, e quindi difendono la tesi che la coscienza sia accessibile solo dal soggetto che fa esperienza dei propri stati mentali in prima persona. Per Dennett non è così, infatti, tutte le attività della nostra mente possono essere riprodotte da un’intelligenza meccanica, un computer, un robot; non c’è differenza tra l’elaborazione d’informazione di una macchina intelligente e l’elaborazione della mente umana. I computer sono artefatti che si avvicinano all’uomo: “ i computer riescono a controllare processi in grado di eseguire compiti che richiedono inferenza, memoria, giudizio, anticipazione; sono generatori di nuove conoscenze, scopritori di strutture, in poesia, in astronomia […] che in precedenza solo gli esseri umani potevano sperare di individuare. La semplice esistenza dei computer ha offerto una prova d’innegabile forza: vi sono meccanismi […] che possiedono molte delle competenze assegnate solo alle menti”.
La teoria che uscirà vincitrice dallo studio sulla coscienza è il funzionalismo, il quale ha già ottenuto successi in altri settori della ricerca scientifica. Così come per calcolare la legge di gravità non è importante conoscere la composizione chimica dei pianeti, per studiare la percezione non è importante sapere il colore degli occhi, allo stesso modo per studiare la mente non è importante il sostrato fisico, l’hardware che implementa il software. Il sostrato materiale può essere composto di transistor, fili elettrici, chip in silicio, ciò che più conta è la computazione indipendentemente dalla materia cerebrale. Così Dennett sostiene un funzionalismo minimalista: “Il funzionalismo è l’idea che il bello è bello in quanto fa bene quello che deve fare […] poiché la scienza è alla ricerca continua di semplificazioni […] il funzionalismo ha un’inclinazione verso il minimalismo, ovvero, che le cose che contano siano meno di quanto si sarebbe potuto pensare”.
Quelli che insistono sul fatto che la coscienza è, in ultima analisi, misteriosa, sono abituati a rimanere sconcertati di fronte all’inesplicabilità degli effetti a noi noti come fenomenologia della coscienza. Il senso comune assegna alla coscienza un velo di mistero e di magia, ma la filosofia di Dennett squarcia il velo; per vedere cos’è realmente lo spettacolo del vivere cosciente, bisogna andare nel retroscena e svelare che quello che sembra uno spettacolo di magia è, appunto, un’illusione come ogni gioco di prestigio che si rispetti. Una volta che saremo in grado di comprendere e riconoscere i modi non misteriosi con cui il cervello lavora, potremo immaginare di costruire una teoria della coscienza senza postulare entità ineffabili. La domanda difficile, l’hard problem, come l’ha definito Chalmers, cioè: “Che cos’è la coscienza?” non ha senso di essere posta, perché non esiste nel nostro cervello un Teatro Cartesiano in cui sono rappresentate tutte le nostre esperienze coscienti, un Sé, un Io, un Re che decide che cosa debba diventare cosciente e cosa invece non ha il diritto di esserlo; al contrario, il cervello è composto di eventi veicolo di contenuto che in maniera anarchica si arrogano il diritto di essere “cerebralmente popolari”, che acquisiscono una certa “fama”. Se la coscienza è l’imperatore e ciò che la costituisce è la sua veste, allora, come dice Voorhees: “ Per Dennett non è l’imperatore senza vestiti, sono i vestiti, piuttosto, che sono senza imperatore”.
Il dialogo finale immaginario tra Psi (psicologia) e Fil (filosofia) ci porta direttamente nella terra dei misteri, la patria dei qualia. I qualia sono le nostre sensazioni soggettive, le nostre esperienze fenomeniche, quello che sperimentiamo in prima persona. I qualia, sostiene Sellars, sono ciò che “rende la nostra vita degna di essere vissuta”. Ad esempio, se ricerco la gioia, lo faccio per quell’intrinseca sensazione soggettiva che mi reca il suo raggiungimento, una sensazione privata e incomunicabile a parole. Ma non esistono i qualia, essi sono il dolce sogno dei filosofi che pensano ancora che esistano proprietà sganciate dalle attività del cervello, che sfuggono alle sue cause ed effetti. In realtà esistono solo proprietà funzionali e relazionali, che possono essere progettate nei sistemi di elaborazione dell’informazione. Per Dennett l’inesistenza dei qualia è un punto non negoziabile all’interno di qualsiasi teoria della coscienza, alla stessa stregua dell’elan vital e della teoria del vitalismo nel momento in cui la scienza ha scoperto, che non solo ne poteva fare a meno ma anche che non esisteva.
Siamo arrivati a un bivio nella ricerca sulla coscienza? Da una parte la coscienza ineffabile e misteriosa e dall’altra la deriva eliminativista ma illuministica di Dennett? Per Dennett una buona teoria della coscienza non tiene conto del Sé, della Volontà Cosciente, dei qualia, e in ultima analisi, della nostra profonda convinzione di essere coscienti. Alla scienza che verrà l’ardua risposta, forse oggi è troppo tardi per la filosofia, aggrappata ancora ai suoi dolci sogni, ma ancora troppo presto per la psicologia.
Stefano Comito
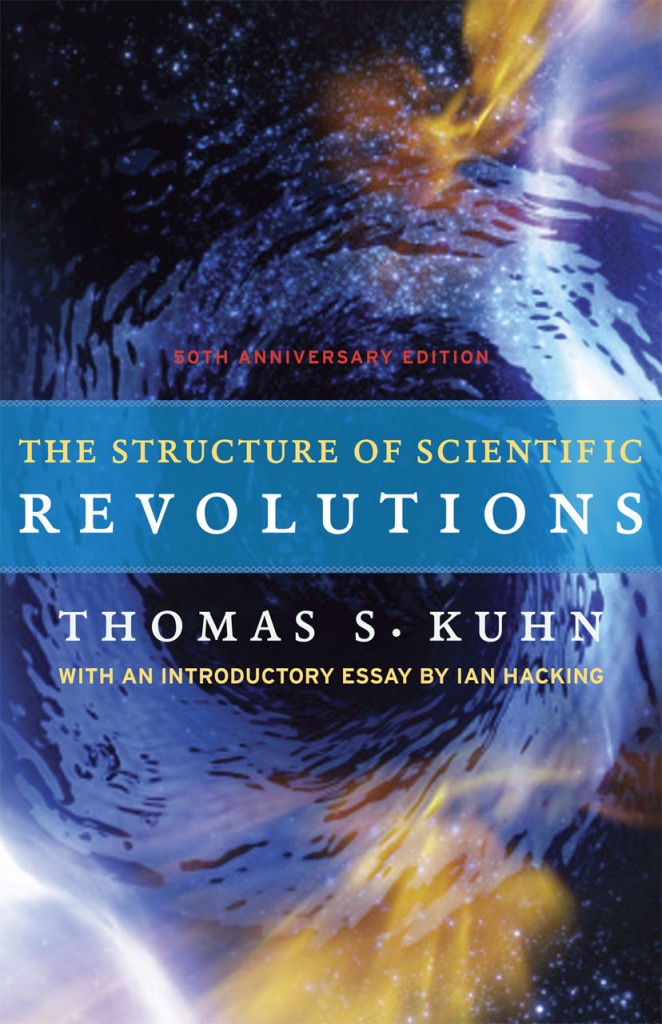 In questo articolo vengono prese in considerazione le idee più importanti del libro di Kuhn sulle rivoluzioni scientifiche, The Structure of Scientific Revolutions (1), fra cui in particolare il concetto di paradigma nella sua componente tacita, automatica, preliminare alla razionalità discorsiva. Viene esplicitato il legame fra la natura del paradigma e la questione dell’incommensurabilità fra le diverse visioni scientifiche, e viene evidenziato il ruolo della comunità scientifica come strumento per fare fronte a tale problema. L’opera in oggetto è presentata come un contributo positivo all’impresa scientifica e non come l’affermazione di un relativismo di origine sociale.
In questo articolo vengono prese in considerazione le idee più importanti del libro di Kuhn sulle rivoluzioni scientifiche, The Structure of Scientific Revolutions (1), fra cui in particolare il concetto di paradigma nella sua componente tacita, automatica, preliminare alla razionalità discorsiva. Viene esplicitato il legame fra la natura del paradigma e la questione dell’incommensurabilità fra le diverse visioni scientifiche, e viene evidenziato il ruolo della comunità scientifica come strumento per fare fronte a tale problema. L’opera in oggetto è presentata come un contributo positivo all’impresa scientifica e non come l’affermazione di un relativismo di origine sociale.