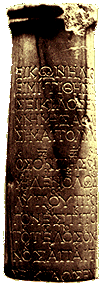
Epitaffio di Sicilo (II secolo aC), il più antico documento musicale greco. Così recita: «Finché vivi, splendi, non affliggerti per nulla: la vita è breve e il Tempo esige il suo tributo»
Se ordini il libro tramite il nostro link, hai diritto ad uno sconto significativo (Amazon): Ricordati di vivere. Goethe e la tradizione degli esercizi spirituali (Scienza e idee)
— — —
a cura di Alessandro Stella
Non è possibile aprire un libro di Pierre Hadot senza provare una profonda ammirazione per questo autore, la cui più autentica erudizione è legata indissolubilmente alla estrema semplicità di parola. Semplicità di parola, certo, ma anche e soprattutto parole semplici. La sua parola ha il senso della bellezza proprio perché evita inutili “filosofemi”, proprio perché è una parola che ha il peso, e la leggerezza, di una vita intera dedicata alla filosofia. La filosofia di Hadot, però, non è quella che l’accademia moderna può suggerire, e cioè un’attività il cui scopo è la costruzione di un sistema concettuale. Anche se la teoria è sempre stata al centro della filosofia, essa fungeva da giustificazione di un modello di vita, di una disciplina: era inseparabile da uno stile di vita. Poco prima di morire, Hadot ha ribadito un concetto espresso in tutta la sua produzione letteraria e in tutta la sua vita: <<Nei tempi antichi, ad esempio in Epitteto, Plutarco, o in Platone, vi è una critica feroce di chi vuole solo “professori” che vogliono brillare con le loro argomentazioni e il loro stile e che sono quindi distinti da coloro che vivono la loro filosofia. Questo stesso contrasto si perpetua nella filosofia moderna. Kant oppone alla filosofia “scolastica” la “filosofia del mondo” che interessa ognuno di noi. Schopenhauer deride la filosofia accademica, che descrive come “scherma di fronte a uno specchio”. Thoreau dichiara: “Ai nostri giorni, ci sono professori di filosofia, ma non filosofi”, e Nietzsche scrive: “abbiamo appreso il minimo delle cose che gli antichi insegnavano alla loro gioventù? Abbiamo imparato il minimo tratto di ascetismo pratico di tutti i filosofi greci?” Bergson e gli esistenzialisti difendono lo stesso concetto, quello di una filosofia che non è una impalcatura di concetti, ma un impegno “di” e nell’esistenza” (1). In questo suo ultimo libro, il cui sottotitolo è Goethe e la tradizione degli esercizi spirituali, l’autore ricorda quel che ha continuato a sviluppare nel corso dei suoi lavori. Le antiche scuole filosofiche hanno sviluppato dei “corpus” di esercizi spirituali, intendendo con ciò “atti dell’intelletto, o immaginazione, o della volontà, caratterizzati dalla loro finalità: tramite loro, l’individuo cerca di cambiare il suo modo di vedere il mondo, al fine di trasformarsi. Non si tratta d’informarsi, ma di formarsi”. In questo lavoro, tramite Goethe, Hadot ci ricorda la filosofia come memento vivere, rielaborando e sfruttando tutta la tradizione greca e lo stesso memento mori.
Perché tras-formarsi? Perché è necessario salvare i beni superiori dell’esistenza e consegnarla alla sua spontaneità, ma il “desiderio” non è pronto a questo compito. Esso, immaturo, ci espone alla miseria, alla servitù, al dolore, alla dipendenza (e nella società postmoderna, più che mai). Di qui la necessità di cautelarsi contro queste tendenze e ad esercitare la mente, la volontà, l’ immaginazione e gli atteggiamenti favorevoli alla vita buona e felice. Poiché sarebbe dannoso credere che i Greci, come una certa letteratura enfatizza, fossero naturalmente disposti alla felicità. L’unico errore del grande Goethe, agli occhi di Pierre Hadot, è di aver idealizzato il greco, l’uomo antico: “l’uomo felice, sano, che vive nel presente”, opposto all’uomo moderno, tormentato dall’aspirazione all’ infinito e dalla condanna della vita terrena operata dal cristianesimo. Per Hadot, quella famosa “salute inconscia” del greco è più una fantasia che una realtà. La bella salute greca è in realtà una conquista, non è un dono; tale conquista è essenzialmente legata all’educazione filosofica.
Come giustamente ha sottolineato Klaus Schneider << la definizione dell’essenza dell’ellenismo, vale a dire, per Winckelmann, dell’ essere umano ideale o della perfezione divina, come “nobile semplicità e quieta grandezza” è tratto dall’ interpretazione di opere d’arte plastica >>, in particolare quelle del IV secolo AC che aveva proposto il famoso archeologo, ma non tenendo conto delle opere letterarie dell’Antichità. Hadot critica così questa rappresentazione idilliaca della vita greca immaginata da Winckelmann e in parte condivisa da Goethe. Hadot cita il grande filologo tedesco August Boeckh che nel 1817 scriveva: “I Greci erano più sfortunati di quanto molti credono”. Schopenhauer, ne “Il mondo come volontà e rappresentazione”, cita testi dei lirici e dei tragici, che raccontano il profondo pessimismo greco: “Il più invidiabile di tutti i beni della terra è quello di non essere mai nato e di non aver mai visto i raggi ardenti del sole; se si è nati, di passare al più presto le porte degli inferi e di riposare sotto una fitta coltre di terra”. Ma è soprattutto Jakob Burckhardt e dopo di lui, Nietzsche, che hanno criticato le idee di Winckelmann e di Goethe nel corso del XIX secolo.
Questa rappresentazione idilliaca della gioia e della salute greca, infatti, difficilmente corrisponde alla realtà storica. L’uomo antico era ugualmente preoccupato, altrettanto ansioso che l’uomo moderno. Hadot spiega che, come noi, portava il peso del passato, le preoccupazioni e le speranze del futuro, la paura della morte. Esiodo evoca le “tristi preoccupazioni” che torturano gli esseri umani dal momento in cui Pandora aprì il vaso dei mali, chiudendo il coperchio sulla speranza. Il genere umano è “la razza di ferro”; durante il giorno, le spetta “la fatica e la miseria, e la notte, le dure angosce inviate dagli dei”. La lirica e i tragici gli fanno eco, quasi ad evocare il Qoelet biblico: “Non c’è uomo felice. Tutti gli uomini che vedono il sole sono pungolati dal dolore” (Solone, fr. 114.). Sulla stessa nota è Sofocle: “Ahimè, o razza dei mortali, la vostra vita è uguale al niente“(Edipo Re, 1186). Goethe ammirava la “salute del momento presente” nei dipinti di Pompei ed Ercolano. Eppure è in quest’epoca che Orazio parla della “nera preoccupazione” (Odi, III, 1, 40) che cavalca inesorabilmente dietro il cavaliere; Lucrezio al contempo descrive l’ansia interiore degli uomini, che fuggono da loro stessi: “Se gli uomini, come si vede che sentono di avere in fondo all’animo un peso che con la sua gravezza li affatica, potessero anche conoscere da che cause ciò provenga e perché una sì grande mole, per così dire, di male nel petto persista, non così passerebbero la vita, come ora per lo più li vediamo: ognuno non sa quel che si voglia e cerca sempre di mutar luogo, quasi potesse deporre il suo peso […]Così ciascuno fugge sé stesso, ma, a quel suo ‘io’, naturalmente, come accade, non potendo sfuggire, malvolentieri gli resta attaccato, e lo odia, perché è malato e non comprende la causa del male” (Lucrezio, De rerum natura, III, 1053 ss.)
 Per Hadot, molto prima dell’analisi di Pascal sulla noia, gli Antichi sentivano questo vuoto, questo odio di sé, la paura di essere soli con se stessi che caratterizza l’essere umano. Seneca ha scritto pagine straordinarie nelle quali analizza le malattie dell’anima che sono l’”odio di sé”, il “piacere che si prova a tormentarsi e a crearsi sofferenza”, “il turbinio dell’anima che non s’impegna in nulla”, il “disgusto della vita e dell’universo” (De tranquillitate animi, II, 6-15). Come Hadot, possiamo supporre che Goethe conoscesse fin troppo bene la letteratura antica da non ignorare certo la preoccupazione e l’ansia dell’uomo antico. Ma credeva che la serenità ellenista fosse così forte che “nei momenti più alti di piacere così come nei peggiori momenti di sacrificio, o addirittura nella distruzione, gli Antichi conservavano una salute indistruttibile” (Winckelmann, HA, t. XII, p. 100-101). Si potrebbe anche pensare che la serenità fosse inerente al temperamento greco. Ma, spiega Hadot, come ben ha visto Nietzsche questa serenità è stata conquistata, è stata il risultato di un immenso sforzo di volontà: era un desiderio estetico di gettare sugli orrori dell’esistenza il velo della creazione artistica, come ha scritto chiaramente lo studioso francese in un altro suo lavoro, “Il velo di Iside”. Ma soprattutto vi era nell’antichità un desiderio filosofico di trovare la pace dell’anima tramite la trasformazione di sé e tramite lo sguardo portato sul mondo.
Per Hadot, molto prima dell’analisi di Pascal sulla noia, gli Antichi sentivano questo vuoto, questo odio di sé, la paura di essere soli con se stessi che caratterizza l’essere umano. Seneca ha scritto pagine straordinarie nelle quali analizza le malattie dell’anima che sono l’”odio di sé”, il “piacere che si prova a tormentarsi e a crearsi sofferenza”, “il turbinio dell’anima che non s’impegna in nulla”, il “disgusto della vita e dell’universo” (De tranquillitate animi, II, 6-15). Come Hadot, possiamo supporre che Goethe conoscesse fin troppo bene la letteratura antica da non ignorare certo la preoccupazione e l’ansia dell’uomo antico. Ma credeva che la serenità ellenista fosse così forte che “nei momenti più alti di piacere così come nei peggiori momenti di sacrificio, o addirittura nella distruzione, gli Antichi conservavano una salute indistruttibile” (Winckelmann, HA, t. XII, p. 100-101). Si potrebbe anche pensare che la serenità fosse inerente al temperamento greco. Ma, spiega Hadot, come ben ha visto Nietzsche questa serenità è stata conquistata, è stata il risultato di un immenso sforzo di volontà: era un desiderio estetico di gettare sugli orrori dell’esistenza il velo della creazione artistica, come ha scritto chiaramente lo studioso francese in un altro suo lavoro, “Il velo di Iside”. Ma soprattutto vi era nell’antichità un desiderio filosofico di trovare la pace dell’anima tramite la trasformazione di sé e tramite lo sguardo portato sul mondo.
Grande e originale lettore di Goethe, dopo qualche critica, Pierre Hadot trova nel tedesco anche un esempio illuminante della tradizione greca degli esercizi spirituali. Il primo capitolo del libro è dedicato all’ ”esercizio caro a Goethe della concentrazione sul momento presente, che permette di vivere intensamente ogni momento dell’esistenza senza essere distratti dal peso del passato o dal miraggio del futuro” . La lettura di questo capitolo è particolarmente gradita dopo la meditazione Pascal che stigmatizza la tendenza umana a disertare il momento presente. Pierre Hadot ricorda le lezioni degli Epicurei e degli Stoici che esortavano gli uomini a reinvestire l’attimo: “Che l’anima trovi la sua gioia nel presente e prenda in odio l’inquietudine del futuro” (Orazio, Odi, II, 16, 25). Lo spirito felice non guarda verso il futuro. Si può essere felici in questo momento, se ragionevolmente si limitano i propri desideri. Per Hadot, non solo possiamo, ma dobbiamo. Invece di pensare a tutta l’intera vita, invece di calcolare speranze e incertezze, dobbiamo cogliere la felicità nel momento presente. Vi è un’urgenza: “Non si nasce che una volta” dice una frase epicurea “Siamo nati una sola volta, e non potremo essere nati una seconda volta; dovremo non essere più per l’eternità. Ma tu, benché non abbia padronanza del domani, stai rinviando la tua felicità. La vita si perde nei rinvii, ed ognuno di noi muore senza aver goduto una sola giornata” (Epicuro, detti Vaticani, § 14). “Mentre parliamo”, spiega Orazio, “il tempo ingeneroso del nostro esistere è già fuggito via. Coglilo quest’attimo [carpe diem] e sul futuro fa’ affidamento meno che puoi ”(Odi, I, 11, 7-8). Il carpe diem di Orazio non è affatto (come spesso è raffigurato) una tavola sensuale, ma è un invito alla conversione, vale a dire alla consapevolezza della vanità dei desideri inutili, una presa di coscienza anche dell’imminenza della morte (come non ricordare Heidegger e la sua filosofia come “presenza” della morte?) e dell’unicità della vita, dell’unicità del momento. In questa prospettiva, ogni momento sembra un meraviglioso dono che riempie colui che lo riceve: “convinci te stesso”, dice Orazio, “del fatto che ogni nuovo giorno che nasce per te sia anche l’ultimo. Così con gratitudine riceverai ogni ora insperata”(Epistole, 1.4, 13-14). Gratitudine, stupore, avevamo già incontrato questi sentimenti tra gli Epicurei. Si sente la stessa meraviglia riconoscendo il momento inaspettato come completamente nuovo e straordinario. Lucrezio afferma: “Se il mondo intero, oggi, per la prima volta, apparisse ai mortali, se all’improvviso, inaspettatamente, sorgesse ai loro occhi, cosa si potrebbe descrivere di più meraviglioso di questo insieme di cui l’immaginazione degli uomini aveva appena osato concepire l’esistenza? ”(De rerum natura, II, 1034-1035).
Per Hadot, il segreto della gioia, della serenità epicurea, è in ultima analisi l’esperienza del piacere che dà la coscienza infinita dell’esistere, anche se solo per un momento. Per dimostrare che un singolo istante di esistenza è sufficiente per dare piacere infinito, gli epicurei si esercitavano a dire ogni giorno: “ho avuto tutto il piacere che potevo sperare”. “Questo”, dice Orazio “passerà la sua vita padrone di se stesso e felice, e potrà dire, ogni giorno: ho vissuto”. Vediamo ancora una volta il ruolo del pensiero della morte nell’epicureismo. Dire ogni sera “ho vissuto” (Odi, III, 29, 41-43), equivale a dire: la mia vita è finita. Equivale a praticare l’esercizio di ripetersi che oggi sarà l’ultimo giorno della mia vita. Ma è proprio questa pratica di consapevolezza della finitezza della vita che rivela il valore infinito del piacere di esistere nel momento. Nella prospettiva della morte, il fatto di esistere, anche se solo per un attimo, prende improvvisamente un valore infinito e dà un piacere di intensità infinita. Possiamo dire senza problemi che vita è finita se ci siamo resi conto che abbiamo già avuto tutto, in questo istante d’ esistenza.
Nello stoicismo, il bisogno di concentrarsi sul presente è ancora più marcato, come è evidente nel pensiero di Marco Aurelio: “Ti basti questo: il presente giudizio sulla realtà, purché sia obiettivo, la presente azione, purché sia al servizio della comunità umana, la presente disposizione interiore, purché sia una disposizione di gioia davanti agli avvenimenti prodotti della causa esterna” (A se stesso, IX, 6). Marco Aurelio si esercita quindi a focalizzare l’attenzione sul momento presente. “Ti basti questo”, per Hadot è una frase a doppio significato: è sufficiente per tenerti occupato, non è necessario pensare a qualcos’altro. Ma è anche abbastanza per farti felice, non c’è bisogno di cercare qualcos’altro. Questo, per Hadot, è l’esercizio spirituale che Marco Aurelio chiama “delimitare il presente”: significa distogliere l’attenzione dal passato e dal futuro per concentrarsi su ciò che si sta facendo. Questo è sufficiente per la nostra felicità, perché è l’unica cosa che ci appartiene, che dipende da noi. Agli occhi degli stoici, infatti, è indispensabile saper distinguere tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi. Il passato non dipende più da noi, in quanto definitivamente accertato, il futuro non dipende da noi, dal momento che non è ancora: ad entrambi dobbiamo essere indifferenti. Solo il presente dipende da noi. E’ l’unica cosa che può essere buono o cattivo, perché è l’unico che dipende dalla nostra volontà (cfr. A se stesso, XII, 3). Allo stesso modo, per Hadot, Seneca descrive questo esercizio come segue: “Ognuno è infelice quanto ritiene di esserlo. Ma evitiamo, io la penso così, di lamentarci per i dolori passati dicendo: <<A nessuno è mai capitato di peggio. Che sofferenze, che mali ho sopportato! Nessuno pensava che mi sarei ripreso. Quante volte i miei mi hanno pianto, quante volte i medici mi hanno dato per spacciato! Nemmeno sotto tortura si soffre tanto>>. Anche se questo è vero, ormai è andata: a che serve rivangare i dolori sofferti ed essere infelice ora perché lo sei stato in passato? Tutti ingigantiscono i loro mali e mentono a se stessi! E poi è piacevole che siano finiti quei dolori che è stato duro sopportare: quando il male finisce, è naturale goderne. Due cose, dunque, vanno eliminate: il timore di un nuovo male e il ricordo di quello vecchio; l’uno ancora non mi tocca, l’altro non mi tocca più” (Lettere a Lucilio, 78, 14).
Il secondo capitolo descrive la funzione catartica dello sguardo dall’alto. Si tratta di prendere una distanza prospettica rispetto alle cose e agli eventi, di mettere le cose in una prospettiva globale che le relativizza e le rende intelligibili, per sbarazzarsi del parziale e di esercitare il proprio punto di vista come se vedessimo il mondo dalla cima di una montagna o dalla luna. Da questa altezza la meschinità e la piccolezza dell’agire umano appare chiaramente, e gli eventi sono rapportati alla loro giusta proporzione. Pierre Hadot sottolinea che questo “sguardo dall’alto” esaltato da Goethe appartiene alla grande tradizione filosofica. Per conoscere e agire con verità e giustizia c’è bisogno di un’ascensione spirituale liberandosi dalla prospettiva terragna e dalla sua cecità. Hadot cita le “regole di vita” di Nietzsche: “Per vivere la vita con piacere devi stare al di sopra di quella! Perciò impara a elevarti! Perciò impara a guardare all’ingiù! Raffina il più nobile impulso con la circospezione: con ogni chilo d’amore prendi un chicco di auto disprezzo!”. Una bella lezione, che è simile a quella di Goethe. Hadot scrive: <<Goethe parla del volo della vita, in questa prospettiva il Genio è finalmente l’uomo vivente. La vita è un volo che si trova tra il celeste ed il terreno, tra il cielo stellato ed i colori della terra. E se la vita è un volo, è anche uno slancio, una aspirazione verso l’infinito che non deve essere disturbata dall’idea di fine e limite. Goethe è qui un discepolo di Spinoza: “La meditazione del saggio non è una meditazione sulla morte, ma sulla vita” (Etica, IV, proposizione 67). Possiamo evocare a questo proposito “Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister”, in cui Wilhelm, visitando la Sala del Passato progettata dallo zio di Natalie, scorge, su un sarcofago, un personaggio intento a leggere un rotolo su cui sono scritte queste parole: “Gedenke zu Leben” (“ricordati di vivere”)>>.
Il terzo capitolo è dedicato all’ esegesi del poema di Goethe “Urworte”, che è una vera e propria descrizione della condizione umana. Questa volta l’esercizio è a livello della speranza, figura che corona il poema e rappresenta un atteggiamento di fondo delle scrittore tedesco. Il quarto capitolo, infine, ha per tema il sì alla vita, rintracciato da Hadot sia nello stoicismo che in Nietzsche: “La mia formula per la grandezza dell’uomo è l’amor fati: che cioè non si vuole nulla diverso da quello che è, non nel futuro, non nel passato, non per tutta l’eternità. Non solo sopportare ciò che è necessario, e tanto meno nasconderlo – tutto l’idealismo è una menzogna di fronte alla necessità – ma amarlo …” (Ecce Homo).
— — —
Note:
(1) Pierre Hadot, Intervista a cura di Thierry Grillet (Nouvel Observateur 10/07/2008).



Non riesco a capire come mai libri come quelli di Hadot rimangano di nicchia quando potrebbero trovare una ben più ampia diffusione per la forza che avrebbero di cambiare il corso della vita di tanti uomini. Sono da anni convinto della capicità rivoluzionaria degli esercizi spirituali degli antichi così come li ha riproposti Pierre Hadot. Ma non si riesce a trovare un gran seguito. Abbiamo più professori che filosofi, più insegnanti di storia della filosofia che “praticanti” la filosofia. Soprattutto perché ci siamo,forse, da tempo dimenticati, come ha cercato di ricordarci Hadot nei suoi libri, che “facere docet philosophia, non dicere”. Come amava dire Seneca, uno che da filosofo seppe perfino morire.
Arriano, forse accade perchè l’Accademia si sente minacciata da alcuni concetti espressi da Hadot
Come non essere d’accordo. Ognuno (molti, tanti, troppi) coltiva il suo orticello, minuscolo davvero; e si compiace delle sue smorfie. Pochi si prendono la responsabilità di far sentire la loro voce; quasi nessuno ha più il coraggio e la forza di dire che bisogna rifondare l’Occidente per rimettere al centro l’uomo invece della merce. La diffusione su vasta scala della filosofia, quella Greca in particolare, potrebbe giocare un ruolo importante per la costruzione di una nuova paideia. Per questo ammiro Martha Nussbaum, studiosa di filosofia antica e filosofa engagé, di cui è appena uscito, per Il mulino, il libro “Creare capacità. Liberarsi dalla dittatura del PIL.
ho letto tanta filosofia molta ne ho dimenticata. poca praticata. talvolta ci è vicina.poi sfugge e l’ora ci trascina. ancora molto da imparare e praticare, prima di insegnare.